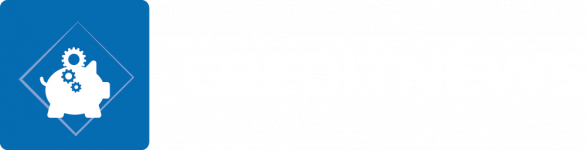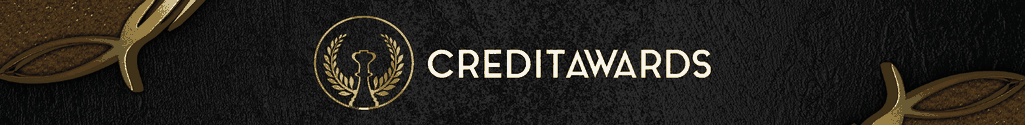Il lending crowdfunding è una valida alternativa alle forme di finanziamento tradizionali. Agire per tutelare gli investitori, però, non sempre è facile. Per questo è fondamentale colmare le lacune normative.
Il lending crowdfunding, noto anche come peer-to-peer lending o social lending, è una forma di finanziamento alternativa che consente di sostenere aziende e individui che non riescono a ottenere finanziamenti dai tradizionali istituti di credito.
Si tratta di un prestito tra privati, il cui incontro viene facilitato dall’accesso a piattaforme online in cui si trovano da un lato soggetti che necessitano di capitali per sviluppare progetti imprenditoriali e dall’altro soggetti disposti a investire il proprio denaro.
Il vantaggio per l’investitore è il guadagno derivante dal rimborso del capitale prestato, maggiorato dagli interessi pattuiti.
Cosa prevedono le piattaforme di lending crowdfunding
Grazie a queste piattaforme, privati e imprese possono ottenere capitale in tempi più rapidi rispetto a quelli di un prestito bancario e con minori condizioni ostative.
Tuttavia, occorre evidenziare che gli interessi sono solitamente più alti del tasso medio bancario.
Si distinguono due diversi modelli di lending crowdfunding:
- il modello diffuso prevede che gli investitori mettano a disposizione il capitale, definendo il profilo di rischio e il tasso di interesse atteso, ma lasciano al portale la scelta del progetto;
- il modello diretto consente agli investitori di decidere su quali progetti investire, compiendo le operazioni direttamente sulla piattaforma.
Chiunque può richiedere un prestito attraverso questo tipo di campagna. Può riguardare sia imprese sia persone fisiche di maggiore età, con un reddito e nessun grave precedente di insolvenza.
Cosa fare contro ritardi e insolvenze
Nel caso in cui il debitore non sia in grado di restituire il finanziamento o incontri difficoltà nel farlo, si troverebbe a dover comunicare con un numero elevato di investitori, ciascuno dei quali ha probabilmente contribuito con importi relativamente modesti. Questa frammentazione può rendere antieconomico avviare azioni di recupero del credito nei confronti del debitore.
Per superare il problema, una possibile soluzione potrebbe essere quella di eleggere la piattaforma di crowfunding come soggetto rappresentativo degli interessi collettivi degli investitori-creditori.
Mediante clausole contrattuali si prevede dunque il conferimento di un mandato da parte degli investitori alla piattaforma, autorizzandola ad agire per conto loro nei confronti del debitore (c.d. “titolare del progetto”).
I limiti della clausole
Le clausole ampliano i poteri della piattaforma, che da semplice intermediario può procedere alla nomina di legali e avviare azioni giudiziarie per il recupero del credito.
L’esigenza di tutela degli investitori, tuttavia, si scontra con alcuni limiti normativi rilevanti, sia nel quadro attuale che in base alle disposizioni precedenti.
Con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive) e il recepimento in Italia tramite il D.lgs. 116/2024, l’attività di recupero crediti può essere svolta solo da soggetti autorizzati, iscritti:
- all’albo previsto dall’art. 114.1 del Testo Unico Bancario (TUB);
- all’albo ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), entro i limiti previsti.
Inoltre, in base al Regolamento (UE) 2020/1503, l’oggetto sociale degli operatori di crowdfunding è limitato esclusivamente alla gestione della piattaforma e ad attività accessorie espressamente previste, escludendo esplicitamente il recupero del credito tra le attività consentite.
Anche la possibilità di nominare un avvocato per conto degli investitori pone questioni di forma. Affinché il mandato alle liti conferito dalla piattaforma all’avvocato sia valido, è necessario che la procura conferita dall’investitore alla piattaforma sia redatta nella stessa forma prevista per il mandato processuale, ovvero:
- scrittura privata autenticata;
- firma digitale qualificata (c.d. “firma forte”).
Nella pratica l’accettazione delle condizioni generali di contratto da parte dell’investitore non avviene quasi mai con queste formalità, rendendo quindi problematico il conferimento effettivo di un valido mandato alle liti.
Un ulteriore limite è legato alla legittimazione attiva: la piattaforma di crowdfunding non può qualificarsi come creditore nei confronti del titolare del progetto. Ciò esclude la possibilità di ricorrere a tecniche tipiche di altri settori del mercato del debito, in cui un rappresentante dei creditori acquisisce formalmente una quota del credito per agire in giudizio. Tale prassi è espressamente esclusa anche dal Considerando 11 del Regolamento 2020/1503, che afferma chiaramente che il fornitore di servizi di crowdfunding non può agire, in nessun momento, come creditore del titolare del progetto.
Colmare le lacune normative per garantire certezza
Il lending crowdfunding rappresenta senza dubbio una grossa opportunità per accedere al credito in modo veloce.
Attualmente, però, è necessario colmare una serie di lacune normative per garantire una reale tutela degli investitori prevedendo, ad esempio, una disciplina regolamentata sul ruolo delle piattaforme in caso di insolvenza o default, e forme di rappresentanza collettiva efficaci.