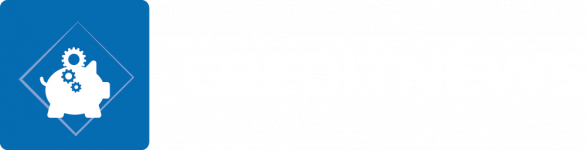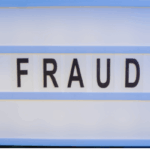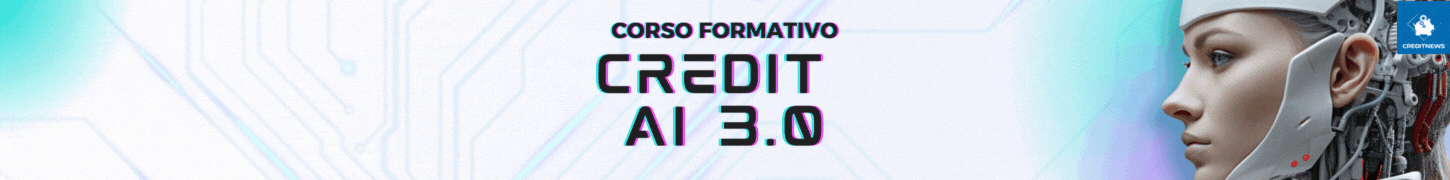Il Nobel per l’economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per i loro studi sui meccanismi della crescita economica legata al progresso tecnologico. Un riconoscimento che celebra la forza dell’innovazione come motore dello sviluppo e della prosperità.
Nobel per l’economia 2025: l’innovazione come motore della crescita sostenuta
Il Nobel per l’economia 2025 premia l’intreccio virtuoso tra conoscenza, tecnologia e competitività. Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono stati insigniti del riconoscimento dalla Sveriges Riksbank “per aver spiegato la crescita economica trainata dall’innovazione”. Un tributo alla capacità della ricerca economica di comprendere i processi che rendono il progresso una forza duratura.
A Joel Mokyr, storico dell’economia di origini olandesi e docente alla Northwestern University, è stato attribuito il merito di “aver identificato i prerequisiti della crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico”. Nei suoi studi, Mokyr analizza il punto di svolta rappresentato dalla Rivoluzione industriale. Quando la conoscenza teorica e quella applicata iniziarono a convergere, alimentando un ciclo continuo di innovazione. Il suo contributo spiega come l’unione tra la conoscenza proposizionale (la comprensione delle leggi naturali) e quella prescrittiva (le istruzioni pratiche per utilizzare tali leggi) abbia trasformato la scienza in un motore di sviluppo economico.
Mokyr riceve metà del premio per aver descritto i meccanismi che legano le scoperte scientifiche alla loro applicazione industriale. Sottolineando come la cultura dell’Illuminismo e l’apertura al cambiamento siano state le vere molle della crescita moderna. È un riconoscimento che premia non solo l’analisi storica, ma anche la visione di lungo periodo su cui poggia ogni progresso duraturo.
La distruzione creatrice: il cuore del progresso economico
L’altra metà del Nobel per l’economia 2025 è stata assegnata a Philippe Aghion e Peter Howitt. Economisti di fama internazionale che hanno teorizzato la “crescita sostenuta attraverso la distruzione creatrice”. La loro ricerca, pubblicata nel 1992, ha costruito un modello matematico in grado di spiegare come il progresso tecnologico determini un equilibrio dinamico tra innovazione e concorrenza.
Secondo la teoria, ogni volta che un’impresa introduce un prodotto o un processo più efficiente, conquista il mercato a scapito delle concorrenti, generando un inevitabile impatto su occupazione e redditività. Questo processo di sostituzione stimola nuove imprese a innovare per riconquistare spazi competitivi. Il risultato è una crescita economica continua, sostenuta dal rinnovamento costante delle strutture produttive.
Il concetto di distruzione creatrice trova così nei modelli di Aghion e Howitt una formalizzazione economica rigorosa, capace di spiegare la relazione tra incentivi all’innovazione e rischio di obsolescenza. I loro studi hanno inoltre aperto la strada a ulteriori ricerche sul grado di concentrazione del mercato e sugli effetti occupazionali del cambiamento tecnologico.
Non a caso, nelle sue prime dichiarazioni dopo l’assegnazione del premio, Philippe Aghion ha richiamato l’importanza di mantenere aperti i mercati globali. Affermando che i dazi sono negativi per la crescita mondiale e ribadendo che l’Europa non può rinunciare alla leadership tecnologica in favore di Stati Uniti e Cina. Una posizione che richiama il dibattito contemporaneo sull’autonomia strategica europea e sulla necessità di investire in innovazione e capitale umano per non perdere competitività.
Il valore del Nobel e il suo significato nel tempo
Il Nobel per l’economia 2025 si inserisce in una tradizione relativamente recente rispetto agli altri premi. I Nobel prendono infatti il nome da Alfred Nobel, inventore della dinamite. Nel suo testamento destinò quasi tutto il suo ingente patrimonio alla creazione di riconoscimenti annuali destinati a chi avesse reso “i maggiori servizi all’umanità” nei campi della fisica, chimica, medicina, letteratura e pace. L’economia, tuttavia, non figurava tra le discipline originarie.
Per colmare questo vuoto, nel 1968, in occasione del suo trecentesimo anniversario, la Banca centrale di Svezia (Sveriges Riksbank) istituì un fondo dedicato alle Scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. Creando così un riconoscimento parallelo, ma equiparato in tutto e per tutto agli altri premi. Dal 1969, quindi, il Nobel per l’economia è diventato un punto di riferimento imprescindibile per la comunità accademica e per le istituzioni internazionali.
L’iter di assegnazione segue le stesse regole previste per gli altri Nobel e anche l’entità del premio è identica: 11 milioni di corone svedesi, poco meno di un milione di euro. A conferma del valore simbolico e materiale che accompagna il riconoscimento.