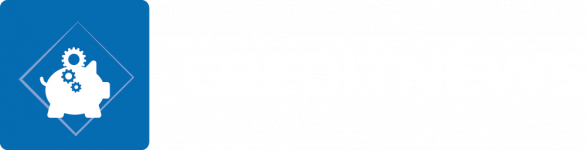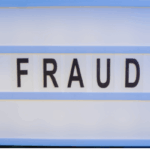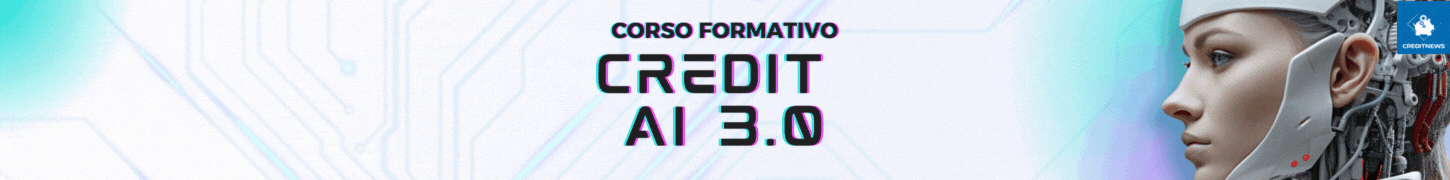Una segnalazione a sofferenza errata può compromettere la reputazione e la sopravvivenza economica di un’impresa. La giurisprudenza ricorda alle banche che l’informazione creditizia non è un automatismo, ma un atto di responsabilità che richiede valutazioni accurate, trasparenza e rispetto dei principi di buona fede e proporzionalità.
Segnalazioni a sofferenza: tutela o abuso di potere informativo?
Nel sistema bancario italiano, le segnalazioni a sofferenza rappresentano uno strumento delicato, concepito per garantire la stabilità del credito e la trasparenza dei rapporti finanziari. Il loro uso improprio può trasformarsi in un’arma capace di danneggiare irrimediabilmente la reputazione e l’affidabilità di un cliente.
La Banca d’Italia, con la Circolare n. 139/1991, stabilisce che l’appostazione a sofferenza non è un automatismo, ma richiede una valutazione complessiva e documentata della situazione economica e patrimoniale del debitore. Non basta dunque un ritardo nei pagamenti o un’inadempienza momentanea. La sofferenza deve corrispondere a una condizione di persistente e grave difficoltà finanziaria, tale da rendere improbabile il recupero del credito.
Segnalare un soggetto in assenza di tali presupposti, o ignorando giustificazioni fondate e richieste di moratoria, significa violare il principio di correttezza bancaria e abusare del potere informativo che la banca detiene nei confronti del sistema creditizio.
Le recenti pronunce: il giudice tutela la proporzionalità
Negli ultimi mesi, diverse decisioni dei tribunali hanno riaffermato la necessità di una condotta prudente e trasparente.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 1° luglio 2024, ha disposto la cancellazione immediata di una segnalazione a sofferenza ritenuta illegittima, sottolineando che la banca non può limitarsi a recepire passivamente le valutazioni di altri soggetti, ma deve rifare integralmente l’istruttoria sullo stato di insolvenza del debitore. Il giudice ha inoltre disposto, l’applicazione di una penalità di 300 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, trascorsi trenta giorni dalla data del provvedimento.
Lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale di Lecce, che nel maggio 2025 ha censurato la condotta di un istituto di credito colpevole di aver rinnovato una segnalazione senza accertare la reale situazione patrimoniale della cliente. E lo ha condannato a rifondere oltre 2.000 euro di spese legali.
Tali pronunce evidenziano come la segnalazione a sofferenza non sia un atto formale, bensì un giudizio di merito che incide profondamente sulla vita economica e sociale del segnalato. Un errore o un’eccessiva superficialità nell’istruttoria possono determinare gravi conseguenze come l’esclusione dall’accesso al credito, la perdita di opportunità commerciali e danni reputazionali difficilmente reversibili.
Garante e debitore: due posizioni distinte e autonome
Un altro punto centrale, recentemente chiarito dalla giurisprudenza e dall’aggiornamento della Circolare Bankit n. 139/1991 (febbraio 2025), riguarda la segnalazione del garante. Essa non può mai essere automatica in conseguenza della segnalazione del debitore principale.
Le posizioni, infatti, sono autonome e devono essere oggetto di valutazioni indipendenti, basate su presupposti specifici. Il garante non può essere considerato “sofferente” solo perché lo è il debitore. La sua situazione finanziaria deve essere analizzata a parte, verificando l’eventuale escussione della garanzia e il suo esito.
Questo principio, confermato da numerose sentenze di merito (Tribunali di Avezzano, Brescia e Cremona), ha una funzione fondamentale, cioè preservare la coerenza e l’attendibilità del sistema della Centrale dei Rischi, evitando che automatismi o eccessi di zelo possano falsare la valutazione complessiva dell’affidabilità creditizia dei soggetti coinvolti.
La gestione delle segnalazioni a sofferenza, dunque, impone alle banche un approccio fondato su prudenza, istruttoria aggiornata e proporzionalità. Solo un’applicazione rigorosa di questi principi può garantire l’equilibrio tra tutela del sistema creditizio e salvaguardia dei diritti del cliente, restituendo al rapporto banca-cliente la dimensione etica e di fiducia che ne costituisce il presupposto più autentico.