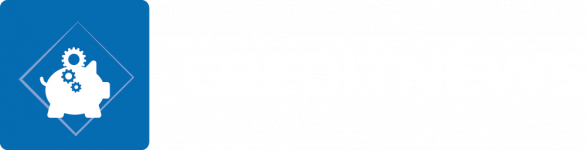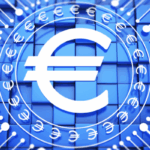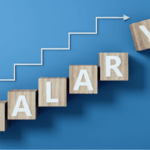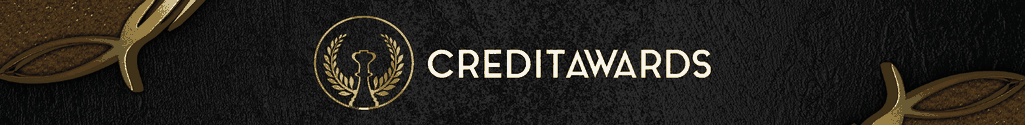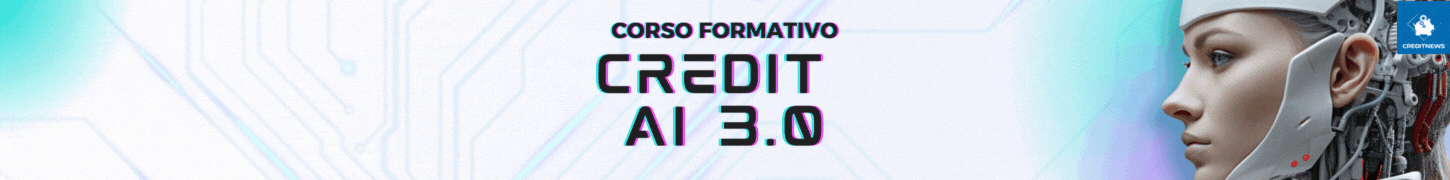La chiusura anticipata dei fondi di Transizione 5.0 obbliga le imprese a fare i conti con una misura partita tardi e finita troppo presto. Le domande già inviate restano valide in ordine cronologico, mentre l’attenzione si sposta sul nuovo programma 2026 basato sui maxi-ammortamenti.
Transizione 5.0: perché i fondi si sono esauriti e cosa accade ora
Il piano Transizione 5.0, pensato per sostenere investimenti digitali e di efficientamento energetico nel biennio 2024–2025, ha terminato rapidamente le proprie risorse. Il piano disponeva inizialmente di 6,3 miliardi, poi ridotti a 2,5 miliardi con la revisione del PNRR. Il decreto attuativo, arrivato solo nell’agosto 2024, ne ha rallentato la partenza e la complessità normativa ha frenato l’adesione delle imprese.
Il contesto è cambiato con la Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto semplificazioni significative, come l’unione dei primi due scaglioni e la presunzione di risparmio energetico per gli investimenti sostitutivi di beni obsoleti. Anche FAQ e chiarimenti pubblicati da Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e GSE (Gestore dei servizi energetici) hanno contribuito a rendere più accessibile la misura.
Nella seconda metà del 2025 le richieste sono aumentate con forza, superando i 2,8 miliardi di euro già il 6 novembre. Per evitare il superamento del limite concordato con la Commissione UE, il Mimit ha chiuso la piattaforma, consentendo solo il completamento delle domande già presentate.
Le imprese che hanno già inviato la documentazione possono procedere regolarmente. Le richieste saranno gestite anche se il totale dovesse superare il tetto disponibile. La possibilità di una riapertura è considerata remota e dipende esclusivamente da eventuali rinunce.
Cosa resta da fare alle imprese e quali criticità rimangono aperte
Nonostante la chiusura, per le imprese esistono ancora margini di azione. Entro il 31 dicembre 2025 è comunque possibile trasmettere la prenotazione sul portale GSE per fissare la propria posizione cronologica, anche se la ricevuta segnalerà l’indisponibilità di fondi. È opportuno verificare che tutta la documentazione sia completa e coerente, soprattutto nei casi in cui siano stati effettuati ordini e acconti. Il versamento di almeno il 20% rimane condizione essenziale per la validità della domanda.
Le imprese dovrebbero inoltre conservare accuratamente contratti, ordini, collaudi e prove di pagamento in vista di eventuali controlli. Un monitoraggio costante del portale GSE è necessario per intercettare aggiornamenti o possibili scorrimenti delle richieste.
Un punto particolarmente delicato riguarda le aziende che hanno già avviato progetti di innovazione nel 2025, confidando nell’accesso al credito 5.0. Se il nuovo incentivo 2026 dovesse basarsi sulla stessa logica dell’avvio del piano 5.0, che aveva validità solo per ordini successivi al 1° gennaio 2026, molte imprese rischierebbero di essere escluse. Sarebbe opportuno che il Governo adottasse un criterio coerente con l’articolo 109 del TUIR, che considera effettuato l’investimento al momento della consegna e del collaudo, non dell’ordine.
L’esperienza di Transizione 5.0 rivela una criticità strutturale, ossia la mancanza di regole semplici e tempi certi. Una misura nata per accompagnare una trasformazione profonda si è ritrovata a funzionare con finestre temporali molto brevi, creando una corsa finale che ha generato confusione e ha spinto molte imprese a riversare i propri progetti sul vecchio Transizione 4.0, esaurendo rapidamente anche quel fondo.
Il nuovo scenario 2026: maxi-ammortamenti e ritorno a una politica industriale più stabile
Esaurita la Transizione 5.0, la politica industriale si sposta ora verso il nuovo piano incentivi previsto per il 2026. Il Governo ha delineato un programma da 4 miliardi di euro basato sui maxi-ammortamenti, che sostituirà definitivamente i crediti d’imposta. L’obiettivo è offrire uno strumento stabile, semplice da applicare e più prevedibile.
Il nuovo modello, ispirato al piano Industria 4.0, riconoscerà maggiorazioni fiscali differenziate sulla base dell’entità dell’investimento, con incrementi particolarmente vantaggiosi per le imprese che raggiungeranno obiettivi di riduzione dei consumi energetici. Il piano comprenderà investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, oltre a soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e impianti di stoccaggio.
A livello territoriale, la legge di bilancio introduce inoltre un credito d’imposta triennale per la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, attivo dal 2026 al 2028. Restano escluse, almeno per ora, le attività di formazione e innovazione tecnologica, mentre potrebbero aprirsi spazi limitati per il credito d’imposta del 10% dedicato all’ideazione estetica.