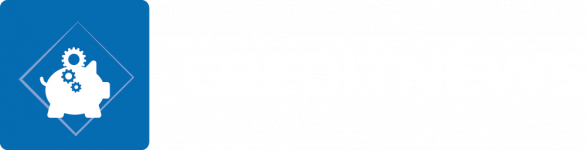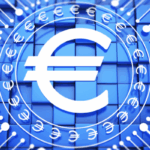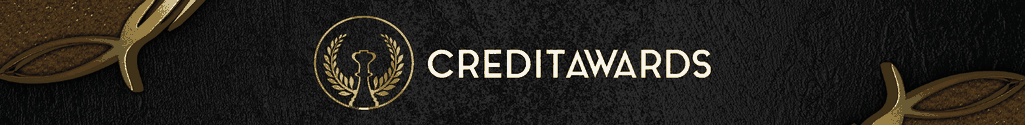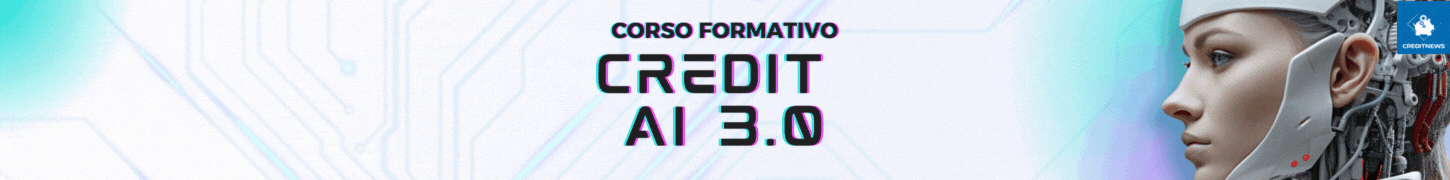L’aliquota Irpef per i redditi tra 28 e 50mila euro scenderà dal 35% al 33%, con aumenti in busta paga fino a 440 euro. Allo studio anche l’estensione della flat tax e la revisione del fiscal drag.
Dal 1° gennaio 2026 il governo Meloni punta a introdurre una nuova riduzione dell’Irpef che interesserà lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. In concreto, il piano – del valore potenziale di circa 3 miliardi di euro per le casse pubbliche – prevede di abbassare l’aliquota dal 35% al 33% per la fascia di reddito compresa tra 28mila e 50mila euro. Il taglio potrebbe coinvolgere circa 10 milioni di contribuenti. Secondo le stime del Ministero dell’Economia, il risparmio varierà da 40 a 440 euro l’anno, a seconda del livello di reddito.
L’obiettivo del governo è duplice: da un lato sostenere il cosiddetto “ceto medio”, ovvero quello maggiormente colpito dall’aumento del costo della vita, dall’altro proseguire nel percorso di semplificazione del sistema fiscale, dopo il primo intervento che aveva portato, lo scorso anno, al 23% l’aliquota sui redditi fino a 28mila euro.
Lo scenario di risparmio per fasce di reddito
L’effetto reale della riduzione Irpef varierà in base al reddito imponibile. Le simulazioni elaborate dai Consulenti del Lavoro mostrano indicativamente quanto inciderà il nuovo scaglione al 33% sul portafoglio dei contribuenti:
- chi percepisce 30mila euro annui avrà un risparmio di circa 40 euro;
- con 35mila euro, la riduzione sale a 140 euro;
- a 40mila euro, il beneficio stimato è di 240 euro;
- a 45mila euro, lo sconto fiscale raggiunge i 340 euro;
- per i redditi di 50mila euro, si arriva al risparmio massimo di 440 euro.
Alcune stime indicano che la riduzione potrebbe rimanere costante anche per i redditi superiori a 50mila euro e fino a 63.500 euro, se il governo decidesse di estendere la misura oltre la soglia inizialmente prevista.
Cosa cambia sopra i 50mila euro
Resta dunque aperto il capitolo sui redditi più alti. Nella precedente riforma fiscale, i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro erano stati esclusi dal beneficio, e anzi avevano subito una riduzione delle detrazioni. Ora il governo sta valutando se alzare la soglia di “inclusione” e consentire anche ai redditi più alti di beneficiare del taglio Irpef.
Secondo i dati del Ministero dell’Economia, circa 3 milioni di italiani dichiarano oltre 50mila euro l’anno, mentre solo l’1,8% supera i 100mila euro. Escludere queste fasce comporterebbe un risparmio per l’erario stimato intorno ai 200 milioni di euro, ma l’effetto sulla platea dei beneficiari sarebbe poco significativo.
Tra le ipotesi allo studio c’è anche un tetto variabile legato ai figli a carico, una sorta di “quoziente familiare” che consentirebbe di calibrare le detrazioni in modo più equo e coerente con la composizione del nucleo familiare.
Tredicesime, pensioni e flat tax
Accanto alla revisione dell’Irpef, la manovra di fine anno potrebbe includere ulteriori interventi fiscali a favore dei lavoratori e dei pensionati:
- Detassazione delle tredicesime, anche per chi percepisce trattamenti pensionistici. La misura è sostenuta da Forza Italia, che chiede inoltre di detassare straordinari e premi di produzione.
- Estensione della Flat tax del 15% per i lavoratori autonomi, con possibile innalzamento del tetto da 85mila a 100mila euro di reddito annuo. L’intervento è richiesto dalla Lega.
- Rimodulazione dei bonus edilizi, che nel 2026 potrebbero scendere al 30% per prime e seconde case. Possibile proroga del credito di imposta del 50% solo sui lavori nelle prime case.
Il nodo del fiscal drag: la richiesta dei sindacati
Il fronte sindacale insiste invece per il recupero del fiscal drag, ovvero l’aumento automatico della pressione fiscale dovuto all’inflazione. Quando i salari nominali crescono, ma gli scaglioni Irpef restano invariati, una quota più ampia di reddito finisce in fasce più alte, generando un gettito aggiuntivo per lo Stato. Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il valore di questo meccanismo è pari a circa 3,3 miliardi di euro all’anno.