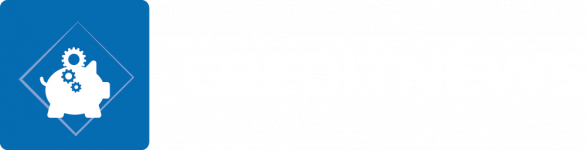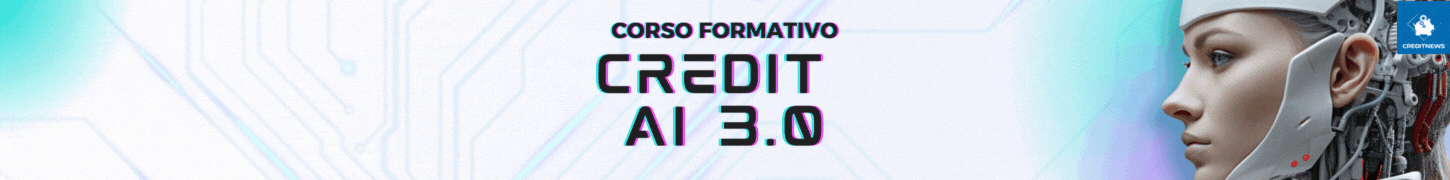Prende forma il cosiddetto Correttivo ter, un intervento di ampia portata che innova profondamente il Codice della Crisi d’impresa. Tra i principali obiettivi: migliorare la prevenzione, rafforzare la professionalità degli operatori, rendere più efficiente la composizione negoziata e disciplinare il trattamento dei crediti fiscali e previdenziali.
Codice della Crisi d’impresa: professionisti al centro del decreto
A due anni dalla sua piena entrata in vigore, il Codice della Crisi d’impresa subisce una profonda revisione, dettata non solo dall’esigenza di coordinare il dettato normativo e superare ambiguità interpretative, ma anche dagli impegni assunti con il PNRR. Il Correttivo ter mira a consolidare un impianto giuridico che privilegia l’emersione tempestiva della crisi, il ricorso a soluzioni stragiudiziali e la valorizzazione delle competenze professionali.
In questo senso, il decreto rafforza il ruolo dei professionisti coinvolti, sottolineando requisiti stringenti in materia di indipendenza e formazione specialistica. L’art. 358 sancisce, infatti, l’iscrizione all’elenco come condizione essenziale per ricevere incarichi, tenendo conto anche della pregressa esperienza. Si tratta di una svolta di sistema, che punta a garantire la terzietà sostanziale degli operatori e a rendere più efficiente la selezione da parte degli uffici giudiziari.
Inoltre, gli esperti dovranno aggiornare i propri curriculum (art. 13) e potranno continuare a svolgere un ruolo attivo anche dopo la fase negoziale, contribuendo con pareri tecnici e relazioni alla buona riuscita delle trattative. Il loro ruolo si delinea così come centrale per il successo dell’intera procedura di prevenzione.
Composizione negoziata e prevenzione: nuovi confini applicativi
Uno degli interventi più significativi del Correttivo ter al Codice della Crisi d’impresa riguarda l’accessibilità alla composizione negoziata, che potrà ora essere attivata anche in presenza di crisi conclamata o squilibrio economico-finanziario (art. 12). Si supera così la visione limitata alla pre-crisi, ampliando il perimetro operativo di uno strumento concepito per evitare il ricorso immediato alla liquidazione giudiziale.
Il legislatore chiarisce inoltre il quadro normativo in cui si collocano le misure protettive e i rapporti con le banche. L’accesso alla procedura non potrà giustificare di per sé la sospensione o revoca delle linee di credito, né comportare una diversa classificazione prudenziale del credito (art. 16). Le banche, tuttavia, potranno mantenerne la sospensione solo se supportata da motivazioni specifiche e fondate su criteri di vigilanza.
Anche il meccanismo dell’allerta precoce viene precisato: l’art. 3, comma 4, ribadisce che i segnali di allarme devono essere considerati anche in assenza di crisi conclamata, confermando così la funzione anticipatoria degli indicatori. Inoltre, viene esteso l’obbligo di segnalazione ai revisori esterni (art. 25-octies), seppur con garanzie per evitare segnalazioni meramente difensive e non giustificate da reali elementi di rischio.
Crediti fiscali e Codice della Crisi d’impresa: un equilibrio ancora più delicato
Uno dei capitoli più attesi del Codice della Crisi d’impresa, profondamente riformulato dal D.Lgs. 136/2024, è quello relativo alla gestione dei crediti tributari e contributivi, spesso la componente più rilevante dell’indebitamento. In tale ambito, il Correttivo ter interviene con una disciplina articolata che punta a bilanciare le esigenze del Fisco con quelle di continuità dell’impresa.
Nei piani di ristrutturazione e negli accordi, viene prevista la possibilità di omologazione forzosa (cram down fiscale), anche in caso di voto contrario da parte del creditore pubblico. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a rigidi criteri: l’accordo non deve avere natura liquidatoria, il trattamento fiscale non deve essere peggiore rispetto alla liquidazione e l’adesione del creditore pubblico deve risultare determinante per il buon esito della proposta (art. 63).
Nel concordato preventivo, l’art. 88 viene completamente riscritto, uniformandosi al nuovo assetto normativo. La riduzione del credito pubblico sarà legittima solo se parametrata alla reale convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, eliminando ogni riferimento al valore di mercato. Si introduce inoltre la possibilità di estendere la nuova disciplina al concordato di gruppo (art. 284-bis), garantendo coerenza e uniformità tra le varie procedure.